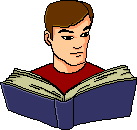
Place alternate text for user who don't have Flash
---------------------------------------------------------------------
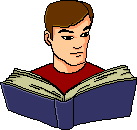
L’ITALIA giolittiana
L’ITALIA giolittiana sostituisce, in
ordine temporale, il tormentato periodo crispino e la scellerata avventura
coloniale voluta dal Primo ministro Crispi; nella battaglia di Adua (1896),
subiamo, dunque, il più clamoroso disastro militare che una nazione
occidentale abbia mai subito in una guerra coloniale, e che costò all’Italia,
in termini di perdite, più delle guerre risorgimentali. Comunque, caduto
definitivamente il gabinetto Crispi, divenne capo del Governo Antonio di
Rudinì , che, almeno all’inizio, parve intraprendere una politica meno
autoritaria e repressiva di quella del suo predecessore: egli introdusse,
oltretutto, blande riforme sociali quali, per esempio, l’assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, o amnistiando qualche
protagonista della rivolta dei Fasci Sicilani, che Crispi aveva schiacciato
brutalmente, tra il 1893 ed il 1894: anno in cui venne anche messo fuori
legge, fino al’96, il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (poi PSI).
Un aumento improvviso del costo del pane, dovuto ad un cattivo raccolto di
grano, nel 1897, fu però fatale per il Primo ministro: di fronte ai
disordini e ai saccheggi del popolo, Di Rudinì proclamò lo stato d’assedio a
Napoli, Firenze e Milano. Proprio a Milano il generale Bava Beccaris, il 7
maggio del ’98, comandò l’Esercito di sparare con l’artiglieria sui
dimostranti: un’ottantina di morti restarono sul selciato: il re Umberto I (
senza alcun tatto diplomatico ) decorò oltretutto il suo fedele, e
delinquenziale, generale con l’ordine militare di Savoia. Naturalmente,
contro questo atto di gratuita brutalità le forze riformiste parlamentari (
"le sinistre") insorsero contro il Di Rudinì, accusato di aver adottato
misure contrarie ai principi basilari della libertà. Anche i conservatori,
comunque, operarono per fare dimettere il Presidente del consiglio, reo,
secondo loro, di scarsa intraprendenza e tempestività nella repressione: se
fosse intervenuto subito (questa era l’accusa) non si sarebbe giunti alle
cannonate in piazza. Tutto pareva spianare la strada ad una gloriosa rentrée
di Giolitti, già primo ministro nel ’92 ed esponente di spicco di un
riformismo moderato che si riconosceva nel liberalismo progressista, ma il
Re decise altrimenti ed assegnò l’incarico ad un suo generale, Luigi Pelloux,
che il parlamento non avrebbe voluto neppure come addetto alle corvées.
Anche Pelloux, secondo ed ultimo esponente di quei governi che la storia
ricorda come "governi della sciabola", recitò all’inizio il ruolo del
pacificatore, smorzando le iniziative poliziesche del De Rudinì, ma, poi,
riaffermò la propria impostazione mentale di stampo militare, proponendo una
serie di atti liberticidi: la restrizione del diritto di sciopero, di
riunione e di associazione, l’allargamento della censura sulla stampa. Unico
risultato dei tentativi di liberticidio legale del Pelloux fu la nascita di
una prassi parlamentare, ad opera della sinistra, che sarebbe divenuta assai
popolare in tempi più prossimi a noi: l’ostruzionismo; nonché lo
schieramento all’opposizione di molti nomi di spicco del liberalismo, tra
cui Zanardelli e lo stesso Giolitti. Le elezioni del giugno 1900 diedero a
Pelloux una maggioranza assai risicata e, date le abitudini trasformiste del
nostro parlamento, certo non tale da garantire buone possibilità di governo,
così egli decise di cedere il passo e la poltrona al presidente del Senato,
Giuseppe Saracco, moderatissimo liberale. Il governo di Saracco durò solo
qualche mese ed è ricordato per i suoi tentennamenti, oltrechè per aver
assistito al regicidio di Umberto I, assassinato a Monza, il 29 luglio del
1900, dall’anarchico Bresci, venuto apposta dagli Stati Uniti a vendicare i
caduti di Milano e le decorazioni di Bava Beccaris.
Dopo la morte di un re che gli agiografi, non trovando niente di meglio,
felicitarono dell’aggettivo "buono", che vuol dire tutto e niente, il suo
successore Vittorio Emanuele III, inaugurò il proprio regno affidando
l’incarico di presiedere il consiglio dei ministri all’insigne giurista
liberale Giuseppe Zanardelli, il padre del nuovo codice penale, che affidò
il dicastero degli Interni proprio a Giolitti, quasi ad indicarlo come suo
alter ego e (evidentemente) successore in pectore. Dopo nemmeno tre anni (novembre
1903) dal suo insediamento, Zanardelli si dimise per motivi di salute: nulla
poteva ormai impedire l’ascesa definitiva di Giovanni Giolitti; e, infatti,
il politico di Dronero subentrò al suo mentore. Lo statista piemontese
sarebbe rimasto al governo, quasi ininterrottamente, fino alla vigilia della
Grande Guerra, dando all’Italia quell’impronta e quel carattere che prendono
il nome di Età Giolittiana. L’ETA’GIOLITTIANA L’Italia che Giolitti si trovò
a governare non era certo un paese prospero o tranquillo, nonostante le
enormi potenzialità che si erano già manifestate: alcune occasioni, come
quella di diventare il porto d’Europa verso il sud-est, dopo l’apertura del
canale di Suez (1869), erano già per buona parte sfumate; l’emigrazione era
una piaga enorme, l’analfabetismo interessava ancora quasi il cinquanta per
cento degli adulti, la rivolta sociale minacciava di scoppiare ad ogni giro
di vite: bisognava costruire infrastrutture, trovare sbocchi lavorativi,
pacificare la società. L’Italia, a differenza di quasi tutti i paesi europei,
non possedeva, salvo la modestissima Somalia, annessa nel 1905, colonie da
cui attingere materie prime a basso costo e verso cui deviare le grandi
masse, soprattutto contadine, di disoccupati o sottoccupati; non aveva
carbone e la sua agricoltura, salvo alcune zone particolari del Paese, era
ad uno stadio arretrato: in seguito al trattato del Bardo, con cui la
Francia, di fatto, si annettè la Tunisia (1881) e ad un’aspra contesa
economica coi transalpini, il governo italiano, nel 1882, aveva aderito ad
un’alleanza difensiva con l’Austria Ungheria e con l’impero germanico, di
cui re Umberto I era grande ammiratore, ma questa alleanza non riscuoteva
grandi entusiasmi nella popolazione, cresciuta nel culto della lotta
risorgimentale contro il "nemico ereditario" e risultava, in termini di
politica estera, poco fruttifera per il nostro Paese. Inoltre, il nostro era
uno stato giovane, scarsamente omogeneo nella popolazione e politicamente
poco evoluto; insomma, Giolitti avrebbe dovuto mettere le mani in un bel
gomitolo di problemi. Ma quello che sarebbe divenuto il "boja labbrone",
aveva le idee chiare, oltre che un fiuto rabdomantico per mantenere la
poltrona; si può ammirare o disprezzare Giolitti per una serie di motivi, ma
un fatto è certo: confronto ai presidenti del consiglio dei nostri giorni,
la sua fu una generazione di giganti! La prima cosa che Giolitti fece, fu di
prendere atto dell’esistenza di un cambiamento in corso nel Paese, dovuto
alla crescita industriale: da una parte erano mutati i presupposti stessi
dei rapporti di lavoro, dall’altra, masse sempre più imponenti di lavoratori
premevano per avere una maggiore importanza come soggetto politico e per
ottenere riforme sociali, aderendo compattamente al Partito Socialista. Il
primo ministro comprese che queste forze politiche non potevano essere,
semplicemente, bollate di sovversivismo e, quindi represse duramente: era
necessario che entrassero, debitamente emendate dei loro aspetti più
eversivi, nel sistema liberale giolittiano. Era la quadratura del cerchio:
da una parte la rinuncia all’utilizzo della forza contro le manifestazioni
dei lavoratori, sancita dall’atteggiamento del governo in occasione del
primo sciopero generale italiano (1904), smorzò l’esasperazione delle
sinistre e, dall’altra, gli imprenditori illuminati videro in questo
paternalismo umanitario la valvola di sfogo che li preservava da problemi
maggiori. Agli imprenditori meno illuminati non restava che assoldare i loro
freikorps privati, per reprimere, per così dire, in proprio, le
manifestazioni sindacali: si tratta di un precedente interessante, che trovò
larga imitazione al tempo dello squadrismo fascista dell’immediato
dopoguerra. L’idea chiave di questa posizione di Giolitti verso il rapporto
tra datori di lavoro e dipendenti prende il nome di "neutralità statale";
essa postulava il non intervento dello stato nella contrattazione tra
domanda ed offerta di lavoro, che dovevano misurarsi solo sul piede di un
libero mercato, unico fattore a determinare i salari. Psicologicamente, così,
agli occhi del proletariato chi era colpevole di eventuali nequizie
salariali non poteva essere lo Stato: Giolitti indicava ai lavoratori nuovi
nemici; non era più il tempo di Bava Beccaris! Il Partito Socialista, nel
frattempo, doveva risolvere una grave crisi interna, che descriviamo un po’
sbrigativamente come il contrasto tra i cosiddetti "rivoluzionari", che
sostenevano la via dal basso al riscatto sociale del proletariato, ed i "riformisti",
che credevano in una possibilità parlamentare di cambiamento della società.
Questi ultimi erano l’interlocutore privilegiato di Giolitti, e, in
particolare, il loro leader Filippo Turati, cui Giolitti propose a più
riprese di fare parte del suo governo. Per evitare di giungere a quella
scissione che, inevitabilmente, poi ci fu, Turati non accettò l’offerta del
primo ministro, pur condividendone l’impostazione politica: lui, Treves,
Bonomi, Bissolati e, in definitiva, coloro che erano l’incarnazione di un
socialismo democratico, si avviavano, inevitabilmente, ad una sconfitta
contro chi li voleva superare a sinistra, come Serrati, Lazzari o il
rampante dirigente rivoluzionario Benito Mussolini, che sarebbe stato
l’autore dell’OdG che li espelleva dal partito, in occasione del congresso
di Reggio Emilia, nel 1912, con il plauso di Lenin. Se i Socialisti
litigavano su tutto, neppure per Giolitti, comunque, erano tutte rose e
fiori, poiché egli doveva perennemente barcamenarsi (attività in cui
eccelleva) tra le tensioni delle sinistre e le preoccupazioni dei moderati:
questo, senza dubbio, rappresentò un forte vincolo alla sua attività
riformista e causò il formarsi di un atteggiamento,a noi, purtroppo, ben
noto, per il quale, più dell’attuazione dei programmi, contava il tenere
unita una maggioranza che appoggiasse il governo, pur indossando la giubba
di Arlecchino: dopo il no di Turati, Giolitti si spostò verso il moderatismo,
strizzando l’occhio ai radicali. Nel panorama politico italiano, tuttavia,
aleggiava l’ombra di un convitato di pietra, che ufficialmente non era un
soggetto politico, ma che lo sarebbe ben presto divenuto e che rappresentava
una larga fetta di elettorato potenziale: il mondo cattolico. L’Italia
risorgimentale fu, senza dubbio, dominata dal laicismo, spesso dalla
massoneria e, qualche volta, dal vero e proprio anticlericalismo: da una
parte c’erano i Savoia, che avevano violato lo Stato della Chiesa e che
avevano costretto il pontefice a rinchiudersi nelle mura leonine, cui si
contrapponeva il "non expedit", il divieto per i cattolici di partecipare
alla vita politica italiana. L’intransigenza pontificia verso i re d’Italia,
però, vuoi per le guarentigie, vuoi perché i tempi cambiano, andava
addolcendosi, e, già nel 1904, Papa Pio X aveva concesso, per arginare i
successi socialisti, ai cattolici di alcuni collegi di votare per i liberali:
si trattava di un passo modesto, ma, in proiezione, di grande importanza. Al
posto delle organizzazioni di cattolici più intransigenti iniziò ad
affermarsi l’Azione Cattolica, di posizioni assai più vicine al sociale (ed
al politico), mentre don Luigi Sturzo poneva le basi per la nascita del
Partito Popolare, che sarebbe divenuto il punto di riferimento
dell’elettorato cattolico italiano. Il rientro ufficiale dell’elettorato
cattolico in politica fu sancito da un patto che impegnava i liberali,
eletti in parlamento coi voti dei cattolici, ad opporsi ad ogni iniziativa
legislativa contraria alla morale cattolica: dal nome del suo ideatore,
questo patto fu noto come "patto Gentiloni"e venne applicato in occasione
delle prime elezioni politiche a suffragio universale maschile, nel 1913.
Nel frattempo, Giolitti cercava di dare la propria impronta al Paese,
mettendo, però, anche in luce quei limiti che la situazione politica poneva
alle sue riforme. La politica estera vide un riavvicinamento progressivo
alla Francia, iniziato nel 1902 con gli accordi Prinetti-Delcassé, che mise
in posizione traballante la Triplice Alleanza e, se vogliamo, pose le
premesse del Patto di Londra del 1915, che segnò lo schieramento dell’Italia
accanto alle potenze dell’Intesa. Il progetto di risanamento del Mezzogiorno
si limitò ad una serie di leggi speciali (niente di nuovo, insomma) che non
dovevano assolutamente ledere gli interessi dei conservatori, che erano
l’espressione della classe dominante meridionale, legata al latifondismo e
con cui il primo ministro tessè rapporti non sempre adamantini. Quando, poi,
mise mano alle infrastrutture, Giolitti dovette mandare avanti un suo
prestanome, Alessandro Fortis, che governò tra il 1905 ed il 1906, giusto in
tempo per fare approvare la legge di nazionalizzazione delle ferrovie,
compreso un articolo che vietava lo sciopero dei ferrovieri, e raccogliere
insulti e proteste del personale ferroviario, cui rispose con la forza
pubblica: il timoniere di Dronero non si era sporcato le mani neppure questa
volta. Nel febbraio 1906, salì al potere il combattivo livornese Sidney
Sonnino, capo dei liberali non giolittiani, quello dell’inchiesta con Jacini
sulle reali condizioni dell’agricoltura nel Mezzogiorno, che subito propose
delle incisive (a dir poco) riforme, a base di bonifiche, ridistribuzione di
terre, ridiscussione dei patti agrari eccetera; con quale entusiasmo delle
baronie meridionali è facile immaginare. A maggio, Sonnino era già giubilato,
a favore del ritorno in pompa magna di Giolitti, che sedette sullo scranno
di primo ministro per quarantadue mesi filati, fino al dicembre del 1909.
Principale atto di governo di questi anni fu la diminuzione dei tassi
d’interesse sui titoli di Stato, che permise di diminuire il debito pubblico:
la legge sulla conversione della rendita. Quando Giolitti, però, ripropose
il suo vecchio progetto sulla tassazione progressiva dei redditi, che già
aveva dovuto accantonare nel 1903, il Parlamento esplose ( a riprova del
fatto che, quando si tocca il portafoglio, sono tutti d’accordo), e
riapparve Sonnino (visto da tutti come l’antigiolitti per antonomasia) che
fece il solito "mordi e fuggi", visto che fu sostituito solo tre mesi dopo
dall’economista Luigi Luzzatti, che, a sua volta, lasciò il posto ad un
quarto governo Giolitti, nel marzo del 1911, caratterizzato da una più
marcata impronta riformista. Fu questo governo che s’imbarcò nell’impresa
libica, anche se il primo ministro, personalmente, non ne era affatto
convinto. Lo costrinsero alla guerra contro la Turchia le pressioni dei
nazionalisti, capeggiati da Enrico Corradini, che chiedevano per l’Italia
"un posto a sole"( e l’ultimo disponibile era, appunto, la Libia), e poi di
quasi tutta l’opinione pubblica, socialisti rivoluzionari esclusi, che
vedeva nella conquista del paese nordafricano la panacea per i problemi del
Paese. Di fatto, chi ne trasse beneficio furono soprattutto i grandi
industriali, che fabbricavano le armi ed i mezzi che la guerra assorbiva. La
Libia nel 1911 nascondeva ancora nel suo sottosuolo quegli enormi giacimenti
di petrolio che ne avrebbero determinato la ricchezza e, in termini
coloniali, l’appetibilità: per molti era solo uno "scatolone di sabbia",
reso desiderabile unicamente da considerazioni di politica coloniale in
chiave antifrancese, dalle ambizioni imperialistiche di un paese giovane e
dalle utopie migratorie di chi vedeva nel paese nordafricano la risposta ai
milioni di italiani costretti a migrare verso le Americhe o l’Australia.
D’altra parte, anche quando le truppe dell’Asse arrivarono ad arrestare la
propria offensiva ad Alamein, nel 1942, afflitte da una terribile penuria di
carburante, una sorte ironica le faceva transitare per la via Balbia sopra
alcuni dei depositi petroliferi più cospicui del mondo, senza che nessuno ne
sospettasse l’esistenza! Dei giorni della polemica sull’intervento o meno
dell’Italia in Libia, quando il governo non assumeva una posizione chiara a
riguardo, è la nascita del mito di un Giolitti espressione vivente
dell’Italietta, un paese mediocre, incapace di grandi progetti e grandi
imprese, governato da un primo ministro vile e sornione; immagine che avrà
grande fortuna nel periodo fascista ed oltre. Più per conservarsi la
poltrona che per un reale convincimento politico, Giolitti ruppe gli indugi
e, subissato di contumelie da parte socialista, dichiarò guerra all’Impero
Ottomano e fece sbarcare le truppe a Tripoli, il 29 settembre del 1911. Nel
1912, col trattato di Losanna, la Libia divenne una colonia italiana, con in
soprammercato Rodi e le isolette del Dodecaneso. La guerra era tutt’altro
che finita, però: nell’interno del paese continuava una guerriglia che fu
contrastata da parte nostra con sistemi, a dir poco, sbrigativi, e che durò
fino agli anni Trenta. Già durante il conflitto, comunque, i nostri soldati
si erano mostrati assai diversi da quel popolo di bonaccioni che tanto
dovette alla leggenda degli "Italiani brava gente": il lancio di gas
velenosi (da noi stigmatizzato, quando lo applicarono gli austroungarici,
sul San Michele, nella Grande Guerra) e le rappresaglie contro obiettivi
civili sono un’invenzione tutta italiana, che ebbe nella guerra libica il
suo laboratorio ideale. Al di là di qualche assegnazione di terre, perloppiù
di difficile bonifica, tutto ciò che il proletariato italiano ottenne dalla
guerra di Libia fu, da una parte, di partecipare alle prove generali di un
dramma che l’avrebbe visto, di li a pochi anni, protagonista sull’Isonzo e
sul Carso, e dall’altra di ottenere, in nome di un diritto acquisito
combattendo, una legge che assegnava il diritto di voto a tutti i maschi
maggiorenni; legge, questa, voluta da Giolitti per riconciliarsi con le
sinistre, insorte, in nome del pacifismo, contro la "gesta d’oltremare".
Nonostante questa dimostrazione di accondiscendenza, la stella del politico
piemontese si avviava al declino, e le elezioni del 1913 non fecero che
confermarlo, portando a Giolitti una maggioranza estremamente eterogenea e
divisa, tanto che, nel marzo del 1914, egli dovette lasciare il posto ad un
conservatore come Antonio Salandra, espressione del liberalismo di destra.
In realtà, più che la fortuna politica di Giovanni Giolitti, ciò che
tramontava era la fiducia in un sistema come quello democratico e liberale,
che lui rappresentava: la guerra di Libia aveva messo a nudo i limiti di una
politica giocata con reti di alleanze finalizzate alla sola conservazione
del potere, portando alla ribalta una politica più legata alla piazza,
dominata dai tribuni, più che dai diplomatici, e, soprattutto, in cui il
conflitto sociale assumeva toni di aperto scontro, che presero nelle
manifestazioni della "settimana rossa", del giugno 1914, i connotati di una
vera e propria insurrezione. L’attentato di Serajevo, pochi giorni dopo (28
giugno 1914), avrebbe catalizzato l’attenzione del mondo, spezzando la Belle
Epoque e dando il via ad uno dei più spaventosi conflitti della storia: con
l’Italietta giolittiana, tramontava tutto un mondo, fatto di eleganza ed
ingiustizia, che per secoli aveva caratterizzato l’Europa. Al loro risveglio,
dopo l’immane catastrofe, i cittadini europei avrebbero constatato che nulla
era più lo stesso.