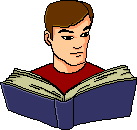
Place alternate text for user who don't have Flash
---------------------------------------------------------------------
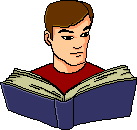
LA SECONDA GUERRA MONDIALE.
LA
MAREA dell'odio 1939-1940
Il potenziale militare tedesco nel 1939.
Hitler si era meticolosamente preparato all’eventualità della guerra, anche
se andava dicendo ai suoi più stretti collaboratori, compreso il Duce, che
non sarebbe stato pronto militarmente (ed era vero) prima del 1942-43.
Quello che però avrebbe potuto fare, nel breve tempo a sua disposizione,
l’aveva fatto: la Luftwaffe, l’arma aerea che per molto tempo era vissuta in
clandestinità, sotto le mentite spoglie degli aeroclub privati, si stava
dotando di una flotta di tutto rispetto, collaudata nella guerra civile
spagnola (la Legione Kondor).
Le scelte strategiche dell’aviazione militare, col tempo, però, si
rivelarono errate: si puntò sull’utilizzo massiccio di bombardieri in
picchiata (lo Ju 87, più celebre come ‘Stuka’) e di aeroplani da
bombardamento medio-leggeri, come gli Ju 88, i Do 17 o gli Heinkel 111;
questa scelta, votata all’attacco al suolo di truppe e mezzi corazzati, se
potè rivelarsi molto valida contro nemici aeronauticamente insignificanti,
come i Repubblicani spagnoli o i Polacchi, con un avversario duro ed
organizzato come la Gran Bretagna, contro cui si trattava di bombardare
intere città, si dimostrò perdente.
La Wehrmacht era ritornata ad essere un esercito efficiente, in cui, ai
vecchi generali di scuola "Potsdam" si erano affiancati giovani e brillanti
generali cresciuti nel culto della mobilità e delle armi nuove, come
Guderian, Manstein o i loro capi, Kleist e Rundstedt.
La Kriegsmarine aveva una flotta sottomarina seconda per cifre solo a quella
italiana, ma certamente superiore per qualità dei mezzi, mentre si stava
potenziando la flotta di superficie con nuove unità da battaglia (Bismarck e
Tirpitz), potenti e moderni incrociatori, come il Prinz Eugen e corazzate "tascabili",
come la Graf Von Spee, potentemente armate, ma di tonnellaggio limitato per
sfuggire alle clausole internazionali.
Inoltre, Hitler poteva contare su delle truppe combattenti d’élite, le
Waffen SS, bene armate, bene addestrate e di una fedeltà a tutta prova.
E’ opportuno ricordare che queste Waffen SS non devono essere confuse con le
SS tradizionali, che avevano compiti di polizia politica e segreta e, in
seguito, di sterminio degli Ebrei e di gestione dell’Olocausto nei campi di
sterminio: le WSS erano reparti combattenti, certo fortemente fanatizzati e
politicizzati, ma il cui impegno fu quasi costantemente militare.
All’inizio della campagna di Russia, tuttavia, l’RSHA, l’Ufficio Centrale
per la Sicurezza del Reich, in cui convergevano le forze di polizia di Stato
(Kripo, Gestapo) e quelle di partito (SD), che, in pratica, era nelle mani
del vice di Himmler, Heidrich, organizzò il massacro sul posto degli
abitanti ebrei delle zone occupate, contestualmente all’avanzata
dell’esercito: nel corso di questo genocidio itinerante (500.000 vittime nei
primi sei mesi), nei quattro gruppi che seguivano a brevissima distanza le
truppe d’avanguardia e che sterminavano ebrei e partigiani russi (Einsatzgruppen),
vi era una consistente aliquota di WSS, e, spesso, essi potevano contare
sull’appoggio logistico della Wehrmacht.
Giova aggiungere che la Wehrmacht non aveva, solitamente, rapporti
particolarmente felici con le SS, che avevano,tra l’altro, propri gradi,
diversi da quelli tradizionali (esattamente come la MVSN fascista); anzi,
spesso, come vedremo nei prossimi inserti, proprio tra gli alti ufficiali
dell’Oberkommando Wehrmacht (OKW, d’ora in poi)maturarono numerosi i
complotti antinazisti.
In realtà, è molto difficile stabilire le responsabilità generali di WSS ed
esercito nell’effettuazione, se non nell’organizzazione, dell’Olocausto; per
lo più è pratica storicamente corretta esaminare, laddove sia possibile, i
singoli casi e le relative responsabilità.
Per esempio, un Einsatzkommando, nel luglio 1941, definiva l’esercito "gradevolmente
ben disposto contro gli Ebrei" (Erfreulich gute Einstellung gegen die Juden).
Si devono, inoltre, distinguere i Pogrom non di matrice tedesca, come quello,
terribile, del 28 ottobre 1941, che operarono i Romeni a Odessa.
Ma di tutto questo parleremo nel dettaglio in un prossimo inserto.
Tornando ai preparativi per la guerra, se non era pronto al 100%, nel 1939,
Hitler poteva contare su di un esercito di tutto rispetto, almeno per una
guerra circoscritta nel tempo e nello spazio; esattamente a questo pensavano
all’OKW, quando si cominciò a parlare di Blitzkrieg, di ‘guerra lampo’:
d’altra parte, non erano state fulminee le vittorie politiche del Nazismo?
L’occupazione incruenta dell’Austria e della Cecoslovacchia contribuì
certamente ad accrescere l’ottimismo di Hitler e la fiducia nei propri mezzi;
bisogna dire, però, che dall’altra parte della barricata si stava
colpevolmente sottovalutando il caporale di Braunau.
Gli Alleati nel 1939.
Negli anni ’20, un generale francese del Genio reduce da Verdun, André
Maginot, sottopose al governo un progetto difensivo della frontiera
orientale della Francia, che tenesse conto dell’esperienza fatta nella
terribile battaglia d’arresto del 1916: un sistema flessibile di forti,
blockhaus, opere di scavo ed apprestamenti sotterranei, in grado di
resistere ad urti massicci di truppe e a bombardamenti pesanti e
pesantissimi.
Nacque così la "Linea Maginot", che, anche se il suo ideatore non fece in
tempo a vederne il collaudo, si rivelò uno dei più clamorosi buchi
nell’acqua nella storia delle opere campali, dato che i comandanti francesi
guardarono a lei con una fiducia cieca, abbandonando qualsiasi altra
considerazione (a parte un giovane generale di divisione di larghe vedute,
che farneticava di carri armati e di guerra manovrata: Charles De Gaulle):
solo l’opinione pubblica francese riuscì a fare peggio dei suoi strateghi,
giudicando, con icasticità tutta transalpina, la Linea assolutamente
invalicabile, nientemeno!
Il problema, come vedremo, fu che, se i generali educati a Saint-Cyr erano
ipnotizzati dalla loro idea fissa della "Maginot", i Tedeschi non lo erano
affatto, e, con praticità teutonica, decisero che se la linea difensiva
francese era davvero insuperabile, la cosa migliore era quella di girarle
attorno; il che, puntualmente, fecero.
Poco meglio erano messi gli Inglesi, che, rallentati nel momento cruciale
dalle manie di appeasement di Chamberlain, erano ancora in alto mare, mentre
Hitler invadeva la Boemia e Mussolini si prendeva l’Albania (7 aprile 1939):
l’Home Fleet era ancora la marina militare più potente del mondo, ma
l’esercito era poco numeroso e male comandato e l’aviazione aveva da poco
varato una massiccia operazione di rafforzamento, con l’introduzione in
linea di nuovi modelli di caccia e di bombardieri.
Tuttavia, gli Inglesi, almeno sul versante difensivo, avevano un enorme
vantaggio rispetto agli alleati francesi: tra loro ed il Vecchio Continente
c’era di mezzo il mare e possedevano il Radar, che si sarebbe rivelato
cruciale quando, nell’estate del 1940, durante la Battaglia d’Inghilterra,
non c’erano abbastanza aerei per essere dappertutto e, perciò, bisognava
conoscere quantità ed esatta direzione delle formazioni nemiche.
Anche nel Regno Unito c’era chi, come Winston Churchill, si sgolava sulle
nuove armi e le nuove strategie ad esse legate, ma non gli si dava troppo
credito.
Certamente, se pensiamo al colossale granchio mussoliniano sulla necessità o
meno di costruire portaerei in Italia; o alla scelta di puntare sui biplani
per i caccia e sui trimotori per i bombardieri fatta dall’aviazione italiana,
o, infinitamente peggio, al costume folle dell’industria aeronautica
italiana di costruire modelli di velivoli simili ma non compatibili tra loro
in termini di ricambi, ci rendiamo conto del fatto che, a posteriori, è
facilissimo valutare le esigenze belliche di un paese, ma che, viceversa,
prevederle sia cosa difficile assai.
Per concludere, comunque, possiamo dire che il potenziale militare degli
Alleati era, nel 1939, quantitativamente pari o superiore a quello tedesco,
ma che gli era, invece, di molto inferiore in termini qualitativi e,
soprattutto, strategici, ancorato com’era ad un’idea di difesa fissa che,
come vedremo, permetterà a Hitler di mettere in atto con tutto comodo il suo
piano d’attacco.
Hitler e Stalin.
Un dittatore ben difficilmente si fida di un collega: sa perfettamente che
l’autocrazia si fonda sulla paura, sull’inganno e sul camaleontismo.
Hitler e Stalin non sfuggirono a questa regola: i due non si fidavano l’uno
dell’altro, ma si capirono benissimo quando si trattò di fare a metà di una
razzia.
Oggi, la storiografia corretta, glissa con imbarazzo quando si pone la
domanda fatidica: "Chi ha fatto scoppiare la seconda guerra mondiale?".
Siamo certi che, se la stessa questione si ponesse, alla vigilia degli esami
di Stato, in una qualsiasi classe quinta di una qualsiasi scuola superiore
italiana, posto che l’insegnante, alla fine dell’anno, fosse arrivato fin
qui, il che è da dimostrare, la risposta all’unisono sarebbe: "Hitler!".
Ahimè, sarebbe bello e comodo se le cose fossero andate così: quante
acrobazie retoriche di meno ci sarebbero, a questo punto, sui manuali di
storia!
Stalin costretto ad accordarsi con Hitler perché non pronto alla guerra
contro il male; Stalin che sperava di vedere riconosciuto il legittimo
possesso dell’Urss sulle repubbliche baltiche; Stalin tirato per i baffi e
per i capelli ad accettare l’alleanza nazista dalla sfiducia delle
democrazie occidentali….
Vogliamo dire com’è andata?
Due immensi delinquenti, ragionando da delinquenti, si sono spartiti
cinicamente dei territori la cui unica colpa era quella di trovarsi vasi di
coccio a viaggiare con vasi di ferro; e lo hanno fatto, al di là di ogni
altra considerazione, perché l’essenza del loro potere era la stessa.
Così, sarà bene ricordare una volta per tutte che la seconda guerra mondiale
l’hanno dichiarata e fatta, concordemente, i nazisti tedeschi ed i comunisti
sovietici: mentre Hitler occupava la Polonia da ovest, Stalin invadeva la
Polonia da est, e con lei Estonia, Lettonia e Lituania, considerate costole
della madre Russia.
Dunque, se la diplomazia occidentale, isolandolo, aveva gettato Mussolini
nelle braccia di Hitler, fino alla firma del "Patto d’Acciaio"(22 maggio
1939), che trasformava le dichiarazioni d’amicizia dell’Asse Roma-Berlino in
una vera alleanza militare, lo stesso aveva fatto con Stalin, di cui (anche
questo è bene lo si sappia) nessuno, ad ovest della Berezina, si fidava.
Così, il 23 agosto 1939, in virtù di uno di quei miracoli che solo nelle
rarefatte sfere della diplomazia avvengono, i fucilatori di Barcellona ed i
bombardatori di Guernica si strinsero la mano (con quale entusiasmo degli
antifascisti, che avevano salutato in Stalin la diga contro l’espansione
nazifascista nel mondo, è facile immaginare); e siglarono un patto di non
aggressione che si chiamò patto Ribbentrop-Molotov, dal nome dei due
ministri degli esteri che, materialmente, lo stipularono (non vi state
sognando nulla: è proprio lo stesso Joachim von Ribbentrop impiccato a
Norimberga!).
In un protocollo che, per ovvi motivi, venne tenuto segreto, la Germania
dava il suo benestare all’occupazione sovietica di qualche sparuto paesetto
orientale, come, appunto, le repubbliche baltiche, la Finlandia, la
Bessarabia romena e, naturalmente, una bella fetta di Polonia.
Il Giappone.
La crisi economica del ’29, che aveva messo in ginocchio l’economia di mezzo
mondo, non aveva certo risparmiato il Giappone, che, proprio in quegli anni
stava espandendosi commercialmente in Asia.
Naturalmente, le conseguenza della grande crisi pesarono moltissimo su di un
Paese a forte vocazione industriale, ma del tutto dipendente dall’esterno
per l’approvvigionamento di materie prime e, perciò, dai commerci esteri.
Vedendo crollare il mercato dell’esportazione dei propri prodotti lavorati,
il Giappone si trovò nella necessità di riprendere a praticare quella
politica imperialista, che già era stata sua ai tempi della guerra
russo-giapponese del 1904, iniziando a conquistare territori sul continente
asiatico.
Questo, tra l’altro, nella logica del Mikado, avrebbe risolto sia i problemi
legati a materie prime e ad esportazione, che quelli connessi con
l’esplosione demografica.
Perciò, l’esercito giapponese passò all’offensiva proprio da dove si era
fermato, cioè dalla Manciuria.
Dalla fine della guerra contro la Russia, i Giapponesi occupavano
stabilmente la parte meridionale della Manciuria; non fu per loro difficile
trovare un pretesto per finire l’opera e, infatti, nel settembre del 1931,
le truppe del Sol Levante invasero i territori cinesi, proclamando, cinque
mesi dopo, il libero stato del Manciukuò, che, in realtà, era solo un
satellite nipponico.
Nel 1933, col pretesto della condanna da parte della Società delle Nazioni
per il suo attacco in Manciuria, il Giappone uscì dalla SDN.
Fu, tuttavia, a partire dal 1936, anno fatale, che i Nipponici iniziarono a
fare sul serio, dopo un colpo di stato militare, che trasformò il Mikado in
una sorta di dittatura, salvo restando il ruolo semidivino dell’imperatore;
tra il 1936 ed il 1941, il Giappone operò uno sforzo possente, dotandosi di
forze armate addestratissime e di mezzi aeronavali di prim’ordine, che
sarebbero dovuti servire alla conquista dei territori asiatici.
In Asia, però, c’erano già degli imperialisti che sfruttavano le materie
prime: gli europei.
Dovendo pestare i calli all’Europa, il Giappone si trovò nella necessità di
farsi anche qualche alleato in Occidente, e la sua scelta cadde sui paesi
politicamente più affini ed economicamente con meno interessi in Estremo
Oriente, ossia la Germania e, per conseguenza, l’Italia; ben presto, si
giunse alla firma del "patto anticomintern", tra Giappone e Germania (novembre
1936).
Otto mesi dopo, nel luglio del 1937, il Giappone attaccò di sorpresa la Cina,
senza nemmeno scomodarsi a dichiarare la guerra e, in breve, ne occupò le
regioni più importanti.
In concomitanza con l’invasione giapponese, i nazionalisti ed i comunisti
cinesi, che stavano combattendo una guerra civile tra loro, si misero
d’accordo e formarono un "fronte nazionale", in chiave antinipponica,
riservandosi di riprendere a scannarsi a guerra finita (come, infatti,
accadde), ed iniziarono una guerriglia contro i Giapponesi che durò, senza
soluzione di continuità, fino alla fine della seconda guerra mondiale.
Occupata la Cina, di fronte al Giappone si aprivano le ricche colonie
inglesi e olandesi, nonché l’intero oceano Pacifico, che era, però, nella
sfera d’interessi degli Usa: si trattava di scegliere tra l’accontentarsi e
l’affrontare una guerra.
Ma, come si sa, l’appetito vien mangiando…..
La marea ad Oriente.
L’1 settembre del 1939, alle prime luci dell’alba, le colonne motorizzate
tedesche invadevano la Polonia, dietro il pretesto di restituire alla
madrepatria l’unico sbocco polacco al mare, il cosiddetto "corridoio di
Danzica", che divideva la Prussia occidentale da quella orientale.
In realtà, era solo il primo atto del più pauroso conflitto che la storia
ricordi: la seconda guerra mondiale.
Questa volta, la reazione diplomatica di Francia ed Inghilterra non si fece
attendere, ed entrambe, il 3 settembre, dichiararono guerra alla Germania;
quarantotto ore dopo, USA e Giappone si proclamarono neutrali, mentre
l’Italia coniò, per definire il proprio atteggiamento, il termine "non
belligeranza".
In due settimane, in pratica, la guerra in Polonia era finita, anche se si
sarebbero dovuti aspettare i primi di ottobre per la resa definitiva
dell’esercito polacco: la Blitzkrieg concepita dall’OKW si era mostrata
efficace oltre le più rosee previsioni.
Il 17 settembre, intanto, l’Armata Rossa aveva invaso la Polonia orientale,
a scopo precauzionale; ossia per assicurarsi il rispetto tedesco delle
clausole segrete del patto Ribbentrop-Molotov.
Iniziava per la Polonia un terribile quinquennio di occupazione nazista; fin
dall’inizio, Tedeschi e Sovietici si diedero da fare per sterminare la
classe dirigente polacca, gli ufficiali dell’esercito, gli intellettuali o
anche solo chi sapeva leggere e scrivere.
Intanto si venivano radunando gli ebrei di Polonia, in vista della Endlösung
der Judenfrage, la soluzione finale del problema ebraico: nemmeno un anno
dopo, sarebbe stato aperto, proprio in Polonia, il campo di sterminio di
Auschwitz.
Dopo il crollo della Polonia, però, il cannone ad Est non tacque a lungo: il
30 novembre del 1939, in un clima polare, l’Urss attaccò la Finlandia, con
il pretesto di alcune concessioni territoriali di frontiera.
I Finnici si batterono bene (e si sarebbero battuti bene anche in seguito,
da alleati dei Tedeschi, sul fronte di Karelia e a Leningrado) e solo tre
mesi dopo, il 12 marzo 1940, si arresero e cedettero ai Sovietici i
territori fonte di contesa, conservando, tuttavia, la propria indipendenza.
Diversamente andò alle repubbliche baltiche, occupate dall’Armata Rossa
nella primavera del 1940.
Mentre Francia ed Inghilterra, sul fronte occidentale, giocavano alle belle
statuine, Hitler, il 9 aprile del ’40, attaccò di sorpresa la Danimarca (che
ebbe, per tutta l’occupazione, uno status privilegiato) e la Norvegia (che
faceva gola, per via delle sue miniere di ferro, anche agli Inglesi, che,
però si mossero tardi), conquistandole in un paio di mesi.
La marea ad Occidente.
Attaccando la Polonia con praticamente tutte le forze a sua disposizione,
Hitler aveva rischiato grosso: solo poche divisioni erano rimaste a
presidiare la linea Siegfried, che fronteggiava la francese Maginot, come
Davide con Golia.
Godendo di una superiorità schiacciante, gli Alleati avrebbero potuto
facilmente sfondare il velo difensivo tedesco e puntare, indisturbati, sulla
Saar e sulla Ruhr, che erano il cuore industriale della Germania: le forze
contrapposte erano dell’ordine di venti a uno in loro favore, durante i
giorni cruciali dell’attacco ad oriente.
Il Fuehrer lo sapeva benissimo, e pregò che il suo bluff non venisse
chiamato: un poco alla volta, sottrasse truppe all’ormai risolta campagna di
Polonia e le avviò al Reno.
Intanto, gli Alleati non si decidevano ad intervenire e, benchè la guerra
fosse stata dichiarata a tutti gli effetti, per mesi, sul fronte occidentale
non si sparò che qualche colpo di fucile, tra le due linee contrapposte: era
la drôle de guerre, la guerra matta, in cui l’Europa rimase col fiato
sospeso per ben otto mesi, che, nelle speranze degli Alleati, avrebbero
dovuto piegare l’economia tedesca, con il blocco navale che la Home Fleet
aveva attuato.
Sulle indecisioni degli anglo-francesi, pesava certamente il ricordo degli
spaventosi massacri di venticinque anni prima; essi non volevano ripetere
l’esperienza della guerra di trincea, e, aspettando a piè fermo, al riparo
delle casematte della linea Maginot o dietro la linea dei forti belgi,
l’attacco tedesco, diedero ad Hitler un vantaggio decisivo.
Quando l’armata tedesca fu pronta e le condizioni meteo furono considerate
soddisfacenti, il 10 maggio del 1940, un’imponente massa di aerei e di mezzi
corazzati travolse tutto davanti a sé, dando un’ennesima, terribile,
dimostrazione dell’efficacia della tattica della guerra lampo.
In un mese soltanto, gli eserciti di due tra le più temute potenze del mondo
furono sbaragliati: mentre i Francesi oliavano i loro poderosi cannoni,
nelle torrette corazzate della linea Maginot, i Tedeschi lanciavano
paracadutisti sui forti belgi, superavano i canali olandesi con i gommoni;
soprattutto, facevano passare le loro Panzerdivisionen attraverso le Ardenne,
che i Francesi avevano, col loro solito acume, definito "inattraversabili"
da parte di grosse formazioni corazzate.
Questa volta, il "piano Schlieffen" aveva funzionato: le branche della
tenaglia si erano chiuse sul nemico, grazie alla maggiore velocità delle
truppe corazzate di Hitler rispetto alla fanteria del 1914; naturalmente,
facendo onore alla sua fama di gentiluomo, il Fuehrer si era guardato bene
dal dichiarare ufficialmente guerra a Belgio ed Olanda: i tempi della
cavalleria erano definitivamente tramontati, e si entrava in quelli della
guerra totale.
A questo punto, Mussolini, che aveva scorte per soli tre mesi di guerra ed
aveva a lungo tergiversato con il collega tedesco circa il rispetto del
patto d’acciaio, ritenne che valesse la pena di correre il rischio, dato
l’imminente collasso del sistema difensivo francese; così, il 10 giugno del
1940, dal balcone di palazzo Venezia, il Duce annunciò all’Italia che
eravamo in stato di guerra con la Francia e la Gran Bretagna.
Al canto di "E la Francia l’è una gran troia: Nizza e Savoia ci renderà…",
il 21 giugno del 1940, le truppe italiane ebbero il loro battesimo del fuoco
sul fronte occidentale; l’armistizio fu chiesto dai Francesi tre giorni più
tardi (si erano già arresi ai Tedeschi il giorno 22).
Le nostre truppe, mal condotte e poco attrezzate, erano avanzate di
pochissimi chilometri in territorio francese; e questo primo, modesto scacco,
subito da una nazione ormai alla canna del gas, avrebbe dovuto fare
riflettere i capi dell’esercito sulla improponibilità di una nostra
partecipazione da protagonisti ad un conflitto in cui l’apparato produttivo
aveva un’importanza decisiva.
Viceversa, l’Italia si gettò a capofitto in un’impresa che avrebbe, come
profetizzava il ministro degli esteri Ciano, compromesso il Paese ed il
Regime.
La Francia, nel frattempo, si era arresa, come abbiamo detto, ai Tedeschi:
il doloroso compito di trattare la resa fu affidato ad un vecchio soldato,
l’eroe di Verdun, colui che aveva firmato il celeberrimo bollettino di
guerra intitolato On les aura, che era una sorta di simbolo del valore
francese: il maresciallo Pètain, che fu nominato plenipotenziario dal
Parlamento francese(17 giugno 1940).
Il 22 giugno, nello stesso villaggio di Rethondes in cui era stata firmata
la resa della Germania nel 1918 e sullo stesso vagone, di proprietà del
M.llo Foch, su cui gli ufficiali del Kaiser avevano chiesto l’armistizio, i
Francesi si arresero alla Germania di Hitler.
Il Fuehrer era al settimo cielo: la pugnalata alle spalle era stata
vendicata; i fantasmi di Verdun, della Somme, di Paschendaele, determinavano
ancora i destini d’Europa.
La Francia fu divisa in due parti: Nord e Atlantico occupati militarmente
dai Tedeschi; e Sud, con capitale Vichy, governati da un regime
collaborazionista, presieduto da Pétain con primo ministro Laval.
Esisteva, per la verità, una terza Francia, ancorchè solo virtuale: la "Francia
libera", proclamata dal generale De Gaulle dal suo rifugio londinese e
composta dai reduci francesi che erano riusciti a raggiungere la Gran
Bretagna: dai microfoni della BBC, De Gaulle esortava i Francesi a resistere
contro l’occupazione tedesca, creando quella che sarebbe diventata la
resistenza francese, il Maquis.
Rimane da esaminare un ultimo capitolo della campagna occidentale del 1940,
quello, forse, più enigmatico: Dunkerque.
Verso la fine di maggio, l’esercito britannico, senza più armi pesanti,
senza carri e senza copertura aerea, si trovava circondato nella sacca di
Dunkerque: sarebbe bastato poco, per le armate tedesche, per schiacciare
tutto quello che rimaneva all’Inghilterra in termini di soldati.
Invece, inspiegabilmente, le truppe del Terzo Reich ebbero l’ordine di
fermarsi ed aspettare.
Le ragioni di questo errore tattico, che avrebbe avuto conseguenze alla
lunga decisive sull’esito della guerra, possono essere diverse.
Forse, Hitler temeva (anche se è poco probabile) qualche trucco degli
Inglesi; o, forse, pensava che, mostrando una specie di clemenza verso i
Britannici, questi avrebbero accettato di buon grado una resa a condizione,
in cui Germania e Regno Unito si sarebbero spartiti il pianeta: colonie
all’Inghilterra e Europa nell’orbita nazista.
Oppure, Hitler aveva già in mente l’attacco al vero nemico di sempre, gli
Slavi, e, pensando al Lebensraum , vedeva una pace rapida con l’Inghilterra
come la scorciatoia per l’invasione dell’Urss.
Se pensiamo alle letture di cui Hitler aveva nutrito il proprio fanatismo
(Chamberlain, Gobineau) e al suo rispetto, nato nelle trincee della prima
guerra mondiale, per i soldati britannici, potremmo azzardare che Hitler,
nella sua analisi farneticante della realtà, ritenesse gli Inglesi come
sostanzialmente affini, per razza e carattere, ai Tedeschi; egli, quindi,
sarebbe stato incline a pensare possibile un’alleanza "ariana", contro il
comune nemico slavo, che il gesto di buona volontà di Dunkerque avrebbe
favorito.
Sono solo ipotesi, naturalmente; la verità è che gli Inglesi ebbero il tempo
di inviare a Dunkerque tutti i battelli disponibili (operazione Dynamo),
riportando a casa, tra il 27 maggio ed il 4 giugno, 350.000 uomini, tra cui
100.000 Francesi, mentre i Tedeschi, tardivamente, davano l’attacco alla
sacca e la bombardavano dal cielo.
Forse, dire che Hitler perse la guerra a Dunkerque è un eccesso: in realtà,
almeno fino al 1942, le cose continuarono ad andare bene, e a volte
benissimo, per l’Asse; tuttavia, dalle spiagge di Dunkerque, oltre che
l’esercito inglese, i Britannici portarono a casa qualcosa di più importante
e di invisibile: la volontà di resistere.
--------------------------------------
Il mondo in guerra.
(1940-1943).
1940.
Con l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, Hitler era padrone
dell’Europa continentale: praticamente tutto il Vecchio Continente, dalla
Norvegia alla Sicilia e dalla Polonia a Capo Finisterre, si trovava sotto
l’egida dell’Asse. La Francia, dopo l’armistizio del 22 giugno, era per metà
occupata dalla Wehrmacht e per metà sottoposta al governo collaborazionista
di Vichy; l’atteggiamento francese non era chiaro e, se da una parte c’erano
stati l’appello radiofonico di De Gaulle (18 giugno) da Londra e, per
conseguenza, la nascita della Francia Libera, cui avevano aderito diverse
colonie africane, dall’altra c’era stato l’episodio vergognoso di Mers el-Kebir,
nel quale le navi da battaglia inglesi avevano, proditoriamente, attaccato
la flotta francese nel porto africano, dato che questa si rifiutava di
consegnarsi, obbedendo alle disposizioni dell’armistizio (3 luglio). Il
sentimento antibritannico nelle colonie francesi crebbe, in seguito a questo
e ad altri episodi, come quello, di pochi giorni successivo a Mers el-Kebir,
dell’attacco alla corazzata Richelieu, alla fonda a Dakar: l’intesa tra
Francia Libera ed Inghilterra non fu, fin dall’inizio, idilliaca, e su
questi toni proseguì, fino alla polemica sull’entrata a Parigi di Leclerc,
nel ’44. Prova ne sia il fallimento del tentativo di sbarco anglo-gaullista
proprio a Dakar, il 23 settembre del 1940, in cui il comandante della
piazzaforte respinse con la forza i sedicenti alleati.
Nel frattempo, Hitler aveva offerto alla Gran Bretagna una pace a condizione,
prontamente respinta dal ministro degli Esteri, Lord Halifax (22 luglio);
mentre gli stormi della Luftwaffe avevano già cominciato a colpire obiettivi
sul suolo inglese: iniziava la Battaglia d’Inghilterra. A proposito di
questo scontro leggendario tra le forze aeree tedesche quelle inglesi, è
opportuno sfatare qualche mito e chiarire qualche concetto.
È probabilmente vero ciò che disse Churchill a proposito della Battaglia
d’Inghilterra, cioè che mai tanti avevano dovuto tutto a tanto pochi, però,
oltre ai valorosi piloti della Royal Air Force, almeno tre elementi
giocarono a favore dei britannici in quei due fatali mesi, agosto e
settembre del 1940, in cui si decisero le sorti della guerra. Tanto per
cominciare, gli inglesi possedevano un sistema radar sulle coste che era già
operativo e funzionava egregiamente, il che permise loro di economizzare e
dirigere sul bersaglio gli interventi dei loro intercettori.
In secondo luogo, la loro industria aeronautica lavorava a pieno regime
nella produzione di caccia, mentre quella tedesca tendeva a cambiare
indirizzo ad ogni evoluzione del pensiero strategico hitleriano.
Ultima, potentissima, atout nelle mani degli inglesi era la presenza al
vertice della Luftwaffe del Maresciallo del Reich, Hermann Goering.
Egli, oltre a non avere azzeccato una sola scelta strategica in tutto il
conflitto, era rimasto contrariato, a suo tempo, dai successi della
Wehrmacht nella campagna di Francia, che avevano lasciato un po’ in ombra la
Luftwaffe; perciò, passò il suo tempo a boicottare iniziative anfibie contro
la Gran Bretagna, continuando a promettere al Führer che la sola arma aerea
avrebbe messo in ginocchio gli inglesi, senza neppure degnarsi di andare a
vedere coi propri occhi cosa stava succedendo al fronte. Clamorosamente,
proprio quando, ai primi di settembre, i bombardamenti dei campi d’aviazione
inglesi stavano per piegare la resistenza della Raf, Goering optò per un
cambio di tattica, iniziando i bombardamenti di Londra, tanto spettacolari
quanto, militarmente, poco efficaci. Dato che la promessa di portare alla
resa gli Inglesi bombardandoli dal cielo non era stata mantenuta e che, vuoi
per le condizioni della Manica, vuoi per la presenza preoccupante della Home
Fleet britannica, vuoi per l’incoercibile timore di Hitler per le operazioni
anfibie, l’operazione Seeloewe, ossia lo sbarco tedesco in Inghilterra era
stata, il 17 settembre, "aggiornata" sine die dal Führer, l’autunno vide
solo incursioni terroristiche nei cieli britannici, come quella che, il 14
novembre, distrusse per buona parte la città di Coventry: la Battaglia
d’Inghilterra era perduta. Ma i dispiaceri per i tedeschi non erano finiti:
gli italiani, in Africa, erano passati all’offensiva, conquistando la
Somalia Britannica (10 agosto) e scatenando un’offensiva nel Nordafrica
contro le truppe del generale Wavell (14 settembre); se non che Wavell, dopo
un paio di mesi di stasi, aveva ricacciato le truppe italiane, comandate da
Graziani, in Cirenaica; questo mentre gli Inglesi in A.O.I. avevano
duramente contrattaccato, penetrando in Eritrea ed in Somalia Italiana (gennaio
1941), liberando la Somalia Brit. (marzo 1941) e costringendo il valoroso
comandante italiano, il Duca d’Aosta, alla capitolazione dell’Amba Alagi (18
maggio 1941). Come se non bastasse, il 28 ottobre del 1940, Mussolini aveva
attaccato la Grecia, contando di fare una blitzkrieg balcanica.
La realtà, tragicamente diversa per i nostri soldati, fu quella di un
conflitto in un Paese montuoso, senza strade, con un clima terribile e
contro un nemico che stupì perfino i propri alleati con la sua tenacia ed il
suo valore.
1941.
In Grecia, le nostre truppe, male equipaggiate e peggio comandate,
nonostante prodigi di eroismo, specialmente da parte delle divisioni alpine,
dovettero addirittura retrocedere, ed il conflitto, spostatosi in Albania,
rischiò di trasformarsi in un disastro.
Per evitare questo cataclisma sullo scenario balcanico, contiguo a quello in
cui, di lì a poco, Hitler avrebbe scatenato l’operazione Barbarossa e,
soprattutto, per salvare il suo amico Mussolini da una terribile figuraccia,
Hitler, il 6 aprile del 1941, attaccò la Jugoslavia e la Grecia. Alla fine
del mese, gli Iinglesi evacuarono, dopo soli due mesi dal loro intervento a
favore dei greci, il Paese balcanico, che capitolò.
I preparativi di Barbarossa, però, erano stati in tutta fretta posticipati,
e questo significava dimezzare il tempo utile per sconfiggere il colosso
sovietico prima della stagione piovosa, quella che in Ucraina, secondo un
proverbio, "Con un cucchiaio d’acqua produce un secchio di fango": nel 1941,
la stagione delle grandi piogge, in Russia, sarebbe cominciata il 10 ottobre!
In realtà, l’esercito italiano, pur composto per buona parte da combattenti
di prim’ordine, era del tutto inadeguato in termini tecnici e strategici a
fronteggiare una guerra su vasta scala: gli aeroplani non avevano neppure
sistemi radio efficienti, le navi non avevano sistemi di puntamento
telemetrici e radar, il che le rendeva vulnerabili, soprattutto di notte, le
armi individuali erano antiquate, non c’era un solo modello di carro armato
che potesse anche solo lontanamente competere con gli equivalenti alleati,
sia per peso che per armamento, i rifornimenti erano tragicamente
problematici, sia nei Balcani che in Africa; insomma, tutto ciò che restava
al fante italiano era il proprio valore. Questo valore, purtroppo, rifulse
soprattutto nella disperazione, e senza influire sull’inevitabile esito
dello scontro. A questo si deve aggiungere la quasi proverbiale incapacità
dei comandanti di grandi unità, che faceva uno stridente contrasto col
valore e la capacità dei comandanti ai livelli più bassi, che, viceversa,
furono tra i migliori dell’intero conflitto.------------------------------------------------
Che dire, per esempio, dello
sciagurato comportamento dei nostri ammiragli, che condussero la nostra
bella squadra di Taranto ad una serie di rovesci, di cui la beffa
dell’aereosiluramento dell’11 novembre 1940, che colpì la Cavour, la Duilio
e la Littorio, cioè metà della nostra flotta, alla fonda nel porto pugliese,
non fu che il prologo? La verità, tuttavia, è che l’entrata in guerra
dell’Italia, che, sulla carta, doveva rappresentare un aiuto notevolissimo
per la Germania, si rivelò quasi un peso, distogliendo truppe e materiali
dai progetti hitleriani.
Mentre i suoi U-boot falcidiavano i convogli alleati, Hitler, intanto, si
preparava a quello che sarebbe stato l’attacco più poderoso della storia
militare: quello alla Russia sovietica, che, fin dai tempi del Mein Kampf,
egli aveva prefigurato come dovere politico della Germania
nazionalsocialista e come necessità tedesca di Lebensraum. Intanto, però, ai
successi dei branchi sottomarini di Doenitz e di Prien non corrisposero
uguali successi delle unità di superficie: il 27 maggio del 1941, la
Kriegsmarine perse la sua ammiraglia, probabilmente la più bella nave da
battaglia mai costruita, la Bismarck, resa ingovernabile dal siluro di uno
Swordfish e, in seguito, affondata dai cacciatorpediniere e dalle due navi
di linea Rodney e George V, seicento miglia ad ovest di Brest.
I pensieri di Hitler, però, erano tutti per la grande impresa ad Est: almeno
in apparenza, l’esercito germanico, galvanizzato dai facili successi ad
Occidente, era una macchina poderosa ed invincibile. Il Führer diceva: "Il
peggiore fante tedesco è superiore al migliore fante straniero!". Questa
macchina, però, era in realtà assai meno potente di quanto non sembrasse a
prima vista: era raddoppiato il numero di divisioni corazzate rispetto
all’inizio della guerra, ma i carri erano scesi, in media, da 250 a 190 per
divisione, e l’industria tedesca non riusciva a produrre nemmeno la metà dei
600 carri mensili che aveva promesso. Hitler disponeva di circa 3.300
panzer, che sono una bella cifra, ma che erano solo 700 mezzi in più
rispetto all’esercito che aveva invaso la Francia; e la Russia non era la
Francia! Più dell’ottanta per cento dell’esercito tedesco si muoveva ancora
a piedi e la stragrande maggioranza dell’artiglieria era ippotrainata: ecco
perché la terribile stagione del fango russo non doveva trovare le truppe in
manovra, ed ecco perché il ritardo dovuto alla conquista dei Balcani si
sarebbe rivelato determinante. La vastità del suolo sovietico, infine,
imponeva una schiacciante superiorità aerea; invece, la flotta aerea sul
fronte orientale, all’inizio di "Barbarossa", avrebbe contato solo 720
caccia, 1.160 bombardieri e 120 ricognitori. Il problema vero della macchina
bellica hitleriana, però, è sempre stato il carburante: i carri ne avevano
per soli tre mesi di operazioni.
Hitler avrebbe dovuto pazientare almeno altri tre anni, se voleva avere
qualche possibilità di successo: invece, quella che, all’inizio, parve una
cavalcata trionfale, si trasformò in un terribile calvario. Domenica 22
giugno 1941, tre diversi gruppi d’armate tedeschi, comandati rispettivamente
da Leeb (nord), Bock (centro) e Rundstedt (sud), per un totale di circa tre
milioni di uomini, scatenarono una poderosa offensiva contro l’Urss.
Il 30 di giugno Leeb occupava la Lituania, Minsk venne accerchiata; l’8
luglio Bock era al Dniepr, il 7 agosto l’accerchiamento si estese a
Smolensk, il 25 Leeb entrò a Tallin, in Estonia, e puntò su Leningrado;
Rundstedt invase l’Ucraina e puntò su Odessa, Gomel fu accerchiata; il 19
settembre i tedeschi entrarono a Kiev. Nulla sembrava poter arrestare questa
serie impressionante di manovre a tenaglia, che distrussero un’armata
sovietica dopo l’altra; ma le armate di Stalin erano almeno il triplo di
quello che avevano preventivato gli strateghi dell’OKW. Ormai, i grandi
obiettivi di Hitler sembravano a portata di mano: Leningrado, Mosca,
Stalingrado ed i pozzi petroliferi del Sud.
I sovietici, invece, dopo aver perso Kharkov, Rostov e la Crimea,
contrattaccarono e, a dicembre, per la prima volta bloccarono le truppe del
Reich, a pochi chilometri da Mosca: il 19 dicembre, l’OKW comunicò alle
truppe l’ordine di fortificarsi per la stagione invernale. Nella storia
della Seconda guerra mondiale ci sono stati momenti topici, in cui le cose
avrebbero potuto volgere a favore dell’uno o dell’altro: è quello che i
tedeschi chiamavano Schwerpunkt, punto di gravità, riferendosi a dove
premere per far evolvere favorevolmente una battaglia; certamente, uno di
questi momenti fu il dicembre 1941, perché non solo il sogno hitleriano di
prendere Mosca prima dell’inverno fallì, ma perché, dopo l’attacco
giapponese a Pearl Harbour, il 7 dicembre entrarono in guerra gli Stati
Uniti, con il loro potenziale industriale e militare del tutto
inimmaginabile per le nazioni europee. Churchill aveva vinto: egli aveva
legato ogni sua scelta all’entrata in guerra degli Usa, e quando questo fu
un fatto compiuto, egli seppe che la guerra, presto o tardi, sarebbe stata
fatalmente vinta dagli Alleati. Per il momento, però, ad un osservatore
esterno, la situazione sarebbe apparsa disperata per gli avversari dell’Asse:
la flotta del pacifico americana era stata messa fuori combattimento, Hitler
era alle porte di Mosca e padrone dell’Europa, gli inglesi in Africa erano
stati respinti dalle truppe di Rommel; eppure, proprio quando sembrava che
l’Asse potesse farcela, perse la lena: non ebbe più le energie per andare
avanti, e, da quel momento, le truppe tedesche, italiane e giapponesi
cominciarono, lentamente, prima a fermarsi e poi, inesorabilmente, ad
indietreggiare.
1942.
I successi nipponici in Estremo Oriente diedero la medesima impressione di
fulmineità e di inarrestabilità di quelli tedeschi in Europa: un esercito
valoroso e ben comandato, una forza aerea di prima qualità ed una flotta
grande e moderna permisero ai soldati del Sol Levante di conquistare un
enorme territorio in tempi brevissimi.
Il tallone d’Achille dei giapponesi era la mancanza di materie prime: dopo
le loro conquiste del 1942, essi, in teoria, potevano contare sulle enormi
risorse dei territori conquistati, ma, di fatto, non riuscirono a sfruttarle
che in minima parte. Gli Stati Uniti, viceversa, avevano subito un duro
colpo, a Pearl Harbour, quando gli aerei della squadra dell’ammiraglio
Nagumo avevano fatto a pezzi le navi di linea statunitensi, all’ancora nel
porto hawaiano, ma le loro tre portaerei di squadra erano sfuggite
all’attacco, e la loro industria aveva cominciato a produrre mezzi militari
a pieno regime: il comandante della Marina imperiale, Yamamoto, che ben
conosceva lo spaventoso potenziale bellico americano, era uno dei pochissimi
che non avevano condiviso l’enorme entusiasmo che aveva pervaso il Giappone
dopo il successo di Pearl Harbour, ed i fatti, presto, gli avrebbero dato
ragione. Subito dopo lo scoppio della guerra, ancora nel dicembre del 1941,
i soldati del Tenno avevano occupato Bangkok e l’importantissima base
britannica di Hong Kong; nel gennaio del 1942, in sole quattro settimane, i
giapponesi occuparono la Malesia, presero Manila, sbarcarono nelle Molucche,
in Nuova Guinea e alle Celebes. Il 15 febbraio, capitolò la grande base
inglese di Singapore, con i suoi poderosi cannoni ridicolmente puntati nella
direzione opposta a quella dell’attacco nipponico; i giapponesi sbarcarono
nella Sonda e occuparono Giava (28 febbraio). Per tagliare definitivamente
fuori la Cina, i soldati imperiali invasero, poi, la Birmania: Rangoon cadde
il 7 marzo; due giorni dopo si arrendevano gli ultimi olandesi su Giava.
In aprile si videro l’occupazione nipponica di Sumatra (6) e la resa degli
americani a Bataan, nelle Filippine. Tuttavia, il vento stava già cambiando:
il 7 di maggio i giapponesi subirono una prima sconfitta aeronavale, nel Mar
dei Coralli (anche se, in termini di perdite, finì alla pari) e, il 18 dello
stesso mese, Tokio subì l’onta di un’incursione di bombardieri americani; ma
la vera svolta si ebbe con la battaglia delle Midway (3-5 giugno 1942), in
cui le portaerei americane ebbero la meglio sulle rivali giapponesi del
solito Nagumo, affondandole tutte e quattro e perdendo la sola Yorktown, già
danneggiata nel Mar dei Coralli. I giapponesi, in luglio e agosto sarebbero
avanzati ancora, occupando Guadalcanal, nelle Salomone; ma proprio da
Guadalcanal sarebbe partita la controffensiva statunitense, iniziata con il
celebre sbarco dell’Usmc (United States Marine Corp), il 7 di agosto. In
Africa settentrionale, il 1942 si era aperto con le forze dell’Asse che,
dopo un’offensiva inglese in novembre, che le aveva respinte entro Natale
del 1941 fino a El-Agheila, si preparavano a rispondere. Da El-Agheila, il
21 gennaio partì una controffensiva di Rommel, che avrebbe portato le truppe
italo-tedesche a Bengasi (29 gennaio) e poi a Bir-Hakeim (10 febbraio), da
cui, dopo una lunga stasi operativa, sarebbe partito lo sforzo finale
dell’Asse per arrivare ad Alessandria. Il 27 maggio 1942, la Volpe del
deserto calò il suo gioco, varcò la frontiera egiziana e puntò decisamente
sul delta del Nilo, occupando Tobruk; lo slancio offensivo si esaurì nei
pressi della depressione di Qattara, dove i due eserciti si fronteggiarono
fino al 24 ottobre: la località di massima penetrazione si chiamava "Due
bandiere", in arabo El-Alamein. In Russia, nel frattempo, dopo la lunga
pausa invernale, era iniziato il ciclo operativo del 1942; in Crimea,
Manstein aveva sfondato: l’1 luglio cadde Sebastopoli. Da Kharkov, Voronez e
Rostov, l’esercito tedesco attaccò verso il fiume Don, raggiungendo il Volga
a Dubovka e toccando le difese perimetrali di Stalingrado, il 20 luglio; il
27 agosto, la Wehrmacht era a 120 chilometri dal Caspio e dalle sue immense
riserve petrolifere, mentre, il 12 settembre, iniziava la battaglia di
Stalingrado. Una controffensiva sovietica, scattata il 19 novembre,
accerchiò la 6a armata del Feldmaresciallo Von Paulus, che si era
impadronita di gran parte della città di Stalingrado; a nulla valse il
tentativo di Manstein di aprire un varco nella sacca che circondava le
truppe tedesche; in un clima polare e in condizioni da inferno dantesco, gli
uomini di Paulus andarono incontro all’annientamento, combattendo oltre le
umane possibilità. Goering aveva assicurato 500 tonnellate al giorno di
rifornimenti aerei per i soldati nella sacca: la media giornaliera non
avrebbe, invece, mai superato le 96 tonnellate, mentre la razione di pane
giornaliero sarebbe scesa a 50 grammi per soldato… e, poi, nemmeno a quelli.
Il 2 febbraio 1943 la 6a armata non esisteva più. Nell’immenso dramma
dell’inverno 1942-’43, non può non avere un posto a sé la tragedia
dell’Armir italiana, schierata sul Don, tra ungheresi e romeni. Proprio
questi ultimi cedettero di fronte ad un attacco corazzato sovietico, il 18
novembre 1942; di qui sarebbe derivato l’enorme crollo che travolse l’intero
fronte e che vide gli italiani, nonostante il grande valore di alcuni
reparti, tra cui le tre divisioni alpine, Julia, Cuneense e Tridentina,
affrontare la terribile ritirata che costò quasi centomila uomini all’armata
italiana, sconsideratamente inviata nella steppa senza mezzi di trasporto,
con armi del tutto inadeguate e con un vestiario assolutamente insufficiente.
La fine del 1942 fu anche la fine delle speranze di vittoria dell’Asse: sul
fronte orientale l’esercito tedesco era tutt’altro che sconfitto e, dopo un
arretramento delle proprie posizioni, avrebbe avuto altri successi tattici,
ma le energie per ottenere la vittoria strategica erano esaurite; la
Germania non riusciva a rimpiazzare le proprie perdite, umane e di materiali,
mentre i sovietici continuavano a moltiplicare aerei, carri e cannoni, anche
grazie all’enorme aiuto fornito loro dagli Usa, che arrivarono a trascurare,
a favore della Russia, le forniture di materiali alle proprie truppe nel
Pacifico. Il 23 ottobre il comandante dell’8a armata britannica, Montgomery,
aveva sferrato un attacco poderoso ad El-Alamein ed era riuscito a passare,
nonostante l’incredibile eroismo dei difensori, tra i quali brillò in modo
particolare la divisione paracadustisti Folgore, che si immolò letteralmente
per contendere il terreno, metro per metro, alle preponderanti forze
alleate. Il 13 novembre Montgomery era a Tobruk e il 20, cadeva Bengasi. In
Africa l’anno si concluse con una controffensiva di Rommel a El-Agheila, ma
erano gli ultimi colpi di coda: il 12 maggio del 1943 gli ultimi italiani e
tedeschi, a Capo Bon, si sarebbero arresi. La tappa successiva sarebbe stata
la Sicilia.
------------------------------
A STALINGRADO AD HIROSHIMA
Se il 1942 rappresentò il momento di maggior espansione territoriale delle
forze dell’Asse, con il 1943 esse cominciarono, seppure non sempre in
maniera clamorosa e con qualche ribaltamento di fronte, inesorabilmente a
ritirarsi in tutti gli scenari della guerra.
Dopo la resa di Paulus a
Stalingrado (2 febbraio 1943), sul fronte russo le truppe sovietiche
avanzarono decisamente, conquistando Kursk, Rostov e Kharkov; il 25 di
febbraio, Manstein scatenò una controffensiva nel saliente conquistato,
riprendendo, il 18 marzo, Kharkov e Bielgorod; fino al luglio del 1943, il
fronte russo sarebbe rimasto stabile sulla linea Leningrado/Veliki-Luki/Orel/Kursk/Taganrog.
In Africa settentrionale, dopo lo sfondamento di El Alamein e l’ultimo
tentativo di riscossa dell’Afrika Korps a Kasserine (14-22 febbraio),
appariva chiaro che la situazione stesse precipitando, tant’è che, ai primi
di marzo, Hitler richiamò Rommel in Germania, per evitargli l’umiliazione
della sconfitta; Patton e Montgomery, che guidavano le forze alleate
provenienti rispettivamente da Ovest e da Est, si congiunsero a El-Qattara
l’8 aprile: un mese dopo (12 maggio), le ultime truppe italo-tedesche in
Nordafrica avrebbero capitolato a Capo Bon.
Anche sul fronte del Pacifico
le forze dell’Asse subirono un grave rovescio, anche se le perdite
assommarono, nella circostanza, ad un solo uomo: il 18 aprile, una
squadriglia di Lightning americani, guidati da un’intercettazione dei
servizi segreti, abbatterono l’aereo su cui viaggiava l’ammiraglio Yamamoto;
con lui moriva un eccellente stratega, ma anche l’unico uomo degli alti
comandi nipponici che fosse dotato di un grande realismo e di una chiara
visione dell’andamento del conflitto: si trattò di una perdita gravissima
per il Sol Levante e che avrebbe causato molti guai al Giappone.
Il 1943 segnò, inoltre, l’inizio della campagna di distruzione sistematica
della Germania per mezzo di incursioni aeree; in preparazione allo sbarco
sul suolo francese, la RAF e l’USAAF attaccarono scientificamente i centri
industriali e i porti tedeschi, adottando la tecnica della divisione dei
compiti: gli americani colpivano gli obiettivi di giorno, con i loro B17 e
B24, mentre i Lancaster e gli Stirling inglesi attaccavano di notte, in
formazioni sempre più massicce, che spesso superavano i mille velivoli.
Non era ancora il sistema dell’"Area bombing", cioè del bombardamento a
tappeto indiscriminato, ma ne era certamente il preludio; tutto ciò era
permesso dall’enorme superiorità di mezzi che faceva pendere decisamente la
bilancia dalla parte degli Alleati; la caccia tedesca doveva misurarsi con
formazioni sempre più compatte di incursori e con decine di migliaia di
mitragliere pesanti, che battevano il cielo intorno ai quadrimotori.
L’industria bellica tedesca,
comunque, compì sforzi che hanno del prodigioso, nel periodo 1943-44,
moltiplicando il numero di aerei e di carri armati che uscivano dalle
fabbriche; tuttavia, il divario non poteva che aumentare continuamente,
tanto che, al tempo dello sbarco in Normandia (6 giugno 1944), gli Alleati
erano padroni incontrastati dei cieli, nonostante la comparsa dei primi
caccia tedeschi a reazione, i Me 262.
Ancora più evidente era la
sproporzione di mezzi tra gli angloamericani e la Regia Aeronautica, che si
immolò letteralmente, prima contendendo al nemico i cieli d’Africa e del
Mediterraneo e poi quelli dell’Italia, in una lenta consunzione di uomini e
mezzi.
Nel luglio del 1943, infatti,
gli angloamericani erano sbarcati in Sicilia, conquistando il primo lembo
d’Europa; altri sbarchi, ben più rilevanti, sarebbero seguiti, ma la Sicilia
fu, in un certo senso, una prova generale delle reali capacità difensive
della fortezza europea.
Le truppe italiane opposero poco più di una resistenza simbolica, un po’ per
l’inverosimile sproporzione di mezzi, un po’ per la sensazione che, ormai,
tutto stesse andando a rotoli (il 25 luglio, il MCF avrebbe approvato
l’"Ordine del giorno Grandi", che esautorava Mussolini) e che la cosa
migliore fosse concludere le ostilità il più in fretta possibile.
Ben diverso fu l’atteggiamento delle truppe germaniche, che, soprattutto
nell’interno dell’isola, impegnarono duramente le truppe alleate.
Col 25 luglio e con l’arresto del Duce, si può dire che ebbe inizio quel
processo di scollamento e poi di aperto conflitto che avrebbe diviso il
Paese e causato la Guerra Civile italiana; l’atteggiamento del maresciallo
Badoglio, subentrato a Mussolini nella carica di capo del Governo, alimentò
le incertezze nei nostri soldati: da una parte, era evidente che Badoglio
mirava alla pace e, forse, ad un repentino cambio di schieramento, ma,
dall’altra, per tenere buono l’alleato germanico (che aveva mangiato da
tempo la foglia), egli aveva proclamato, già il 28 luglio, il proseguimento
della guerra al fianco della Germania.
Si preparava l’immensa
tragedia dell’8 settembre, causa di tanti mali e di tanti drammi, i cui
strascichi, ancora oggi, a sessant’anni di distanza, limitano la libertà
politica e la serenità ideologica del nostro Paese; questa tragedia la
dobbiamo, per buona parte, al responsabile principale di un’altra immensa
tragedia, quella di Caporetto: il maresciallo Pietro Badoglio, massone
piemontese e figura sciagurata della storia d’Italia.
L’estate del ’43 vide anche
il riprendere delle iniziative ad Est; nel luglio, i sovietici respinsero un
tentativo germanico a Kursk ed attaccarono con vigore a Viazma, riuscendo,
agli inizi d’agosto, a sfondare il fronte, riconquistare Kharkov e puntare
direttamente al Dniepr; mentre gli Alleati completavano l’occupazione della
Sicilia e Roma veniva dichiarata "città aperta"; intanto, i pozzi
petroliferi di Ploesti, fondamentali per il rifornimento della Germania,
venivano pesantemente bombardati, riducendo drasticamente la capacità di
movimento dei Tedeschi.
In settembre, i Russi presero Smolensk (24 settembre), seguirono il Dniepr
fino a Kiev e conquistarono, infine, l’ex capitale il 6 novembre.
Alla conferenza di Quebec
(11-24 agosto), gli Alleati avevano approvato i piani per lo sbarco in
Europa; da questo momento in poi, la Gran Bretagna avrebbe assistito ad un
accumulo di mezzi senza precedenti, fino al fatidico D-Day.
L’autunno del 1943 vide un
susseguirsi di conferenze diplomatiche alleate: una volta compreso che la
guerra era vinta e che era soltanto questione di tempo, Inghilterra, Usa ed
Urss cominciavano a cercare di avvantaggiarsi nell’inevitabile spartizione;
in ottobre vi fu la Conferenza di Mosca, in novembre quella del Cairo e la
ben più importante Conferenza di Teheran cui presero parte i tre
plenipotenziari alleati: Stalin, Churchill e Roosevelt.
Intanto, in seguito
all’armistizio dell’8 settembre, di cui ci occuperemo in un prossimo inserto,
Mussolini, dopo la sua liberazione dal Gran Sasso e il suo ricovero in
Germania, aveva costituito, nel nord del Paese, un governo repubblicano,
sostenuto dai Tedeschi, la Repubblica Sociale Italiana (23 settembre).
La contromossa di Badoglio fu quella di dichiarare guerra all’ex alleato
germanico (13 ottobre), ribaltando completamente la posizione dell’Italia
monarchica rispetto all’inizio del conflitto.
Mussolini, il 3 novembre, fece arrestare il genero, Galeazzo Ciano, che
avrebbe affrontato il processo di Verona e la fucilazione, insieme ad altri
gerarchi firmatari dell’OdG "Grandi"(12 gennaio 1944).
La fine del 1943 trovò gli Alleati in piena offensiva, con i Russi che
avevano definitivamente riconquistato Korosten, più volte presa e perduta
dai contendenti, e con gli Americani che sbarcavano in Nuova Britannia e
risalivano lentamente la Penisola Italiana, arrestandosi di fronte alla
linea Gustav, che rappresentava il caposaldo invernale tedesco.
Il 22 gennaio del 1944, gli Alleati sbarcarono ad Anzio, a sud di Roma,
cercando di superare il cul de sac rappresentato da Cassino, dove le loro
truppe si dissanguavano senza riuscire a passare; proprio mentre infuriava
la battaglia di Cassino, il comandante in capo tedesco in Italia, Kesselring,
scatenò un’offensiva contro la testa di ponte di Anzio (17-29 febbraio), che,
però, fallì.
Sul fronte orientale, i Russi
stavano ormai avanzando in tutti i settori; il 14 gennaio iniziarono una
poderosa offensiva per liberare Leningrado dall’assedio, il 22 febbraio
l’Armata Rossa entrava a Krivoi-Rog, il 26 marzo i Russi raggiungevano il
Prut e la frontiera rumena.
Questa campagna invernale logorò terribilmente le forze tedesche, che, ormai
vedevano assottigliarsi spaventosamente le proprie risorse, in particolare
di mezzi corazzati, aerei e carburante; ma anche il salasso umano era
terribile.
Mentre gli Americani
bombardavano Budapest , ora sotto il diretto controllo dei Tedeschi e delle
Croci Frecciate, e Bucarest (aprile ’44), le truppe sovietiche conquistavano
Ternopol (5 aprile), Odessa (10 aprile) e, infine, Sebastopoli (9 maggio),
quando si concluse il ciclo operativo invernale.
Da ogni parte del mondo,
stavano, intanto, affluendo truppe per attaccare la fortezza Europa: i
450.000 Francesi della neonata Armée, i Brasiliani, i Palestinesi, gli
Anzacs, i Polacchi, gli Indiani; si avvicinava il momento tanto temuto da
Hitler, quello dell’attacco al Vallo Atlantico.
In realtà, il sistema difensivo della costa francese era tutt’altro che
insuperabile: soltanto nella zona del Pas de Calais la fascia costiera di
batterie a lunga gittata, di blockhaus e di trappole anticarro ed antinave
era efficiente; per il resto, le difese erano poco profonde e piuttosto
approssimative, data la scarsità di riserve (in pratica, due sole divisioni
panzer) e la precarietà degli apprestamenti fissi.
Hitler, è notorio, non credeva all’eventualità di uno sbarco sulle coste
normanne, e nemmeno le comunicazioni del suo ufficio informazioni sui
preparativi alleati valsero a smuoverlo dall’idea che l’azione principale
sarebbe avvenuta sulle basse coste del nord.
Preda delle sue allucinazioni, che si sarebbero acuite in seguito
all’attentato di Rastenburg del 20 luglio, il Fuehrer non si fidava dei
propri generali ed era sempre più spesso preda di un delirio strategico, in
cui spostava divisioni inesistenti e si affidava alle proprie divinazioni
astrologiche e al proprio intuito.
Incredibilmente, perciò, i Tedeschi vennero presi alla sprovvista dallo
sbarco in Normandia, che, altrimenti, avrebbe potuto, per come sono poi
andate le cose, risolversi in un disastro per le pur strapotenti forze
alleate.
Intanto, nell’immediata vigilia di Overlord, gli Americani progredivano nel
Pacifico, sbarcando in Nuova Guinea a Saidor (2 gennaio), nelle Marshall (31
gennaio), nelle Caroline (16 febbraio) e riconquistando Wake (15 maggio) e
Biak (27 maggio).
In Italia, il 17 maggio cadde Cassino e, una settimana più tardi, la 5a
armata del generale Clark si ricongiunse con le truppe sbarcate ad Anzio: la
linea Gustav era caduta.
E’ naturale, però, che il 1944 risulti dominato dall’evento chiave di tutta
la guerra, ossia lo sbarco in Normandia.
All’alba del 6 giugno 1944, si presentò davanti alle coste francesi
un’armata d’invasione forte di 4.126 navi e di più di 15.000 aerei, che
trasportavano la 1a armata Usa e la 2a britannica: la superiorità aerea
alleata era dell’ordine di 50 a 1!
Lo sbarco avvenne al mattino, con la bassa marea, per evidenziare gli
ostacoli antisbarco sommersi: anche questo prese in contropiede il
comandante delle forze di difesa tedesche, Rommel.
Le spiagge su cui sbarcarono gli Americani (Utah e Omaha) e quelle di
competenza britannica e canadese (Gold, Juno e Sword), nella zona tra Caen e
il Cotentin, entrarono per sempre nella storia; il cinema, oltre che la
storiografia, ha contribuito ad alimentarne la leggenda ("Il giorno più
lungo", "Salvate il soldato Ryan"), cui, pertanto, non aggiungeremo altre
parole.
L’8 giugno, gli Americani erano a Bayeux, il 12 a Carentan, il 26 si
arrendeva Cherbourg.
Durante il mese di Luglio, le città normanne caddero una dopo l’altra,
mentre Rommel rimaneva gravemente ferito in un attacco aereo alla sua
vettura; Caen era caduta il 9 luglio, il 19 Saint-Lô, il 30 Avranches, che
avrebbe permesso uno sfondamento, che poi avvenne, in direzione della linea
Somme-Aisne-Marna.
Nel frattempo, anche i Russi non erano rimasti con le mani in mano: le
valorosissime truppe finlandesi avevano alla fine dovuto abbandonare la
linea Mannerheim sotto gli attacchi dell’Armata Rossa (20 giugno); nel nord,
i sovietici avevano invaso la Bielorussia ed i Paesi Baltici, erano
penetrati in suolo polacco all’inizio di luglio e, nel breve volgere del
mese, si erano presentati in Prussia orientale, minacciando direttamente il
territorio del Reich.
La guerra, ormai, si combatteva in Germania, con tutte le conseguenze, anche
psicologiche, che questo poteva comportare; incredibilmente, però, il popolo
tedesco, pur presagendo l’inevitabile disfatta, non manifestava segni di
cedimento nella sua fede per il Fuehrer, e, per la stragrande maggioranza,
avrebbe conservato questa fede incrollabile fino alla fine.
Mentre l’offensiva in Polonia si arrestava e Varsavia insorgeva sotto la
guida del generale polacco Bor, la Romania, invasa per buona parte dalle
truppe sovietiche, si arrendeva; il re fece arrestare il dittatore Antonescu
ed i Tedeschi persero un altro alleato.
Per quanto riguarda il nostro Paese, rinviando l’analisi della guerra civile
ad un prossimo inserto, insieme ad altri temi storici particolarmente
delicati della seconda guerra mondiale, come la Shoà, dobbiamo segnalare il
fatto che, il 15 luglio, il governo si era reinsediato a Roma , dando
l’impressione che, in almeno metà dell’Italia, ci si avviasse verso una
difficile normalizzazione; la strada della pace era, però, ancora lunga:
dopo la caduta di Livorno, di Firenze e di Pisa (19 luglio, 16 e 19 agosto),
i Tedeschi si organizzarono su una nuova linea difensiva invernale, la Linea
Gotica, che attraversava l’appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna.
Nel frattempo, erano affluite al fronte alcune aliquote di truppe italiane
repubblicane, addestrate e riorganizzate in Germania, mentre continuava a
combattere valorosamente la Xa flottiglia MAS del comandante Borghese, cui
affluivano in continuazione volontari, facendone lievitare gli effettivi in
maniera esorbitante.
Anche l’estate del 1944 segnò, infine, una serie di progressi ulteriori
degli Americani e dei Britannici nel Pacifico: nelle Marianne, in Nuova
Guinea e in Birmania, i Giapponesi subirono duri rovesci e dovettero
abbandonare Guam, il 10 agosto.
Dopo le difficoltà iniziali di Overlord, determinate, prevalentemente, dalla
scarsità di porti cui fare affluire l’enorme massa di materiali e mezzi per
rifornire le proprie armate, ora gli Alleati, proseguivano spediti in
territorio francese.
Il 15 agosto vi era stato un notevole sbarco franco-americano in Provenza,
che aveva creato un secondo fronte, stavolta meridionale, per le truppe che
difendevano la Germania da occidente; il 19 dello stesso mese Parigi era
insorta e, il 25, vi erano entrate le truppe alleate, salutate da un
tripudio straordinario.
Il fatto che, insieme agli angloamericani si trovassero gli Sherman di
Leclerc era costato quasi un incidente diplomatico tra Eisenhower e
l’arcigno generale De Gaulle, che, lungo tutta la guerra, aveva cercato di
imporsi come unico interlocutore francese degli Alleati, riuscendovi in
virtù più della sua arroganza che di una sua reale rappresentatività del
popolo francese: erano i primi segnali di come De Gaulle avrebbe
interpretato il concetto di Grandeur, una volta capo della Francia.
Per farla breve, comunque, entro il mese di settembre, tutta la Francia e
buona parte del Belgio erano stati occupati dagli angloamericani, le cui
forze, provenienti dalla Normandia e dalla Provenza, si erano riunite, come
le ganasce di un’immensa tenaglia, a Châtillon-sur-Seine, il 12 settembre.
Le truppe tedesche, però, guidate da Model, che aveva sostituito Kluge,
suicidatosi dopo l’attentato del 20 luglio, si erano per buona parte
sottratte alla trappola; si trattava, tuttavia, di un esercito sconfitto,
deluso e praticamente disarmato, pallido fantasma di quello che aveva
percorso, in senso inverso, le stesse strade nel 1940.
In quello stesso settembre del 1944, la Bulgaria cadeva e chiedeva
l’armistizio ai sovietici, dichiarando guerra alla Germania (7-11 settembre),
mentre le truppe russe e quelle jugoslave del maresciallo Tito si
congiungevano a Negotin, il 15: il cerchio continuava a chiudersi sul Reich.
Ai primi di ottobre, gli Americani forzarono la linea Sigfrido, ad
Aquisgrana, l’Ungheria venne invasa dai sovietici, mentre il generale Bor, a
Varsavia si dovette arrendere ai Tedeschi; il 20 ottobre Tito entrò a
Belgrado: il 13 dicembre Tito annunciò che la futura repubblica jugoslava
sarebbe stata una federazione di sei stati; uno di questi stati comprendeva
l’Istria e buona parte della Venezia Giulia, da cui già da tempo si stavano
eliminando gli elementi nazionali italiani: si stava delineando il dramma
delle foibe, il cui primo atto si era visto dopo l’8 settembre; anche di
questo parleremo diffusamente nell’inserto sui temi scottanti della seconda
guerra mondiale.
La fine del mese vide anche una pesante sconfitta aeronavale giapponese nel
pacifico, con la battaglia di Leyte, in cui comparvero per la prima volta in
numero rilevante gli aerei suicidi, i Kamikaze; quanto a Leyte, l’accanita
resistenza giapponese cessò del tutto a dicembre; in pratica, gli unici
settori in cui le truppe del Tenno non fossero in aperta crisi restavano la
Cina e l’Indocina, dove le loro offensive raggiunsero buoni risultati, sia
contro Ciang Kai-Scek che contro gli Americani, per il resto, la superiorità
aeronavale degli Usa era troppo marcata per lasciare spazio a qualche
speranza.
La guerra, di fatto, avrebbe potuto finire qui, almeno per quanto riguarda
il fronte occidentale: ben presto, le avanguardie di Patton avrebbero,
incredibilmente, trovato un ponte intatto sul Reno, a Remagen (6 marzo 1945)
, e di lì la porta era praticamente spalancata fino a Berlino, giacchè non
esistevano tra il Reno e la capitale forze consistenti, fatte salve le
divisioni corazzate di Rundstedt, celate nella foresta delle Ardenne, ma
quelle sarebbero dovute servire a tutt’altro.
A questo si opposero due eventi: il primo fu la scelta, tutta politica,
degli Americani di lasciare ai Sovietici l’onore della conquista della
capitale del Reich, ennesima prova del fascino incomprensibile che Stalin
esercitava su Roosevelt.
Il secondo dipese esclusivamente dai Tedeschi e dalla loro disperata volontà
di non arrendersi.
---------------------------
Il 16 dicembre, infatti, con scorte di carburante decisamente irrisorie e
confidando in un fattore aleatorio come il cattivo tempo che costringesse a
terra gli aerei alleati, i carri Tiger germanici sbucarono all’improvviso
nelle linee americane, seminando lo scompiglio: era la battaglia delle
Ardenne, l’ultimo grande sforzo offensivo di Hitler.
In verità, nei piani del Fuehrer questo doveva essere un secondo attacco
alla Francia, con esiti disastrosi e, forse, definitivi per le truppe
sbarcate in Normandia, che dovevano essere tagliate fuori; ma, nella realtà,
l’offensiva delle Ardenne avrebbe, al massimo, potuto scompigliare il fianco
settentrionale delle armate Usa: di fatto, i carri tedeschi si ingolfarono
intorno alla piazzaforte di Bastogne, senza neppure superare la Mosa.
Il 28 dicembre, gli Americani liberarono Bastogne dall’assedio e a metà di
gennaio 1945 l’offensiva era stata del tutto rintuzzata, con la distruzione
dei reparti corazzati nazisti.
Bisogna dire che le truppe germaniche a sud di Strasburgo se la stavano
cavando meglio, tuttavia, in pratica, a febbraio, gli alleati costeggiavano
il Reno per quasi tutto il suo percorso, fino alla conquista di Colonia e,
come già detto, di Remagen, ai primi di marzo.
Naturalmente, in tutto questo periodo, non era passato un solo giorno senza
che massicce formazioni di bombardieri avessero scaricato migliaia di
tonnellate di bombe sul Reich: le città tedesche, ormai, sembravano città
lunari, con scheletri di case smozzicate che sorgevano in un mare di macerie.
Tra tutte, citiamo Dresda, che, pur non rappresentando un bersaglio
strategico, ed essendo stata, per questo motivo, fino ad allora risparmiata
(le fabbriche di strumenti ottici si trovavano fuori del perimetro urbano,
ed erano già state colpite), venne attaccata a più riprese, tra il 13 ed il
14 marzo.
Nella città si trovavano almeno 500.000 profughi, provenienti dalla Slesia e
fuggiti di fronte alla ferocia sovietica; su di loro e sugli abitanti
dell’antica capitale sassone, alle 22 del 13 marzo cominciano a piovere
bombe da due tonnellate, destinate soprattutto ad infrangere i vetri su di
un vasto raggio, per facilitare il propagarsi degli incendi.
Tre ondate di bombardieri Lancaster e B17 (più di 1.100 in tutto)
sganciarono sulla città 650.000 bombe incendiarie, trasformando Dresda in un
ciclone di fuoco che si autoalimentava per la depressione barometrica;
nessuno scampo per gli abitanti, soffocati nei rifugi o arsi per strada,
nessuna possibilità di soccorso, perché i cacciabombardieri americani
mitragliavano senza pietà i carri dei pompieri che provenivano dalle città
vicine: Dresda fu un episodio di una ferocia inaudita in una guerra che era
stata inauditamente feroce, e causò circa 150.000 vittime, cioè più di
qualunque altro bombardamento della guerra, compreso quello di Hiroshima!
Perfino il parlamento britannico insorse per questo atto di barbarie; ma
nessuno ebbe il coraggio di dire che il bombardamento era stato
espressamente chiesto dai sovietici, per scompigliare le retrovie del fronte
orientale.
Il quale fronte, ormai, stava a sua volta crollando: il 13 febbraio Budapest
si arrendeva, ai primi di marzo l’Armata Rossa entrò in Austria e nella
Germania orientale, nello stesso momento cadeva la Pomerania; un poco alla
volta, le forze sovietiche stringevano Berlino, cui Eisenhower aveva
ufficialmente rinunciato, in una morsa.
Da questo momento in poi, ogni giorno segnò uno sviluppo deciso verso la
fine del Reich: vediamo di riassumere gli avvenimenti in modo sintetico.
Il 10 aprile cadde Königsberg, il 12, il giorno della morte del presidente
americano Roosevelt, cui succedette Truman, i Russi entrarono a Vienna, il
16 iniziò l’offensiva congiunta di Zukov e di Konev contro Berlino, il 17 si
arresero le truppe della Ruhr, il 19 gli Alleati, in Italia, forzarono la
linea gotica e presero Bologna, il 27 veniva assassinato Mussolini, il 29 i
Francesi che avevano attaccato da nord e gli Alleati si congiunsero, a
Torino, il 30 aprile Hitler si suicidava nel bunker della cancelleria,
insieme alla moglie, Eva e, il 7 maggio, a Reims, le truppe tedesche si
arresero senza condizioni.
La guerra in Europa si concludeva, con il suo strascico di drammi e di
polemiche: alla fine, gli Americani avevano commesso l’errore di assecondare
troppo Stalin, e questo si sarebbe ritorto contro di loro.
Le conferenze di Yalta (4-12 febbraio) e di Potsdam (17 luglio), in pratica,
sancirono la divisione del mondo in due, consegnando una parte dell’Europa
all’incubo comunista.
Churchill, sconfitto dal laburista Attlee alle elezioni di luglio 1945,
riferendosi al suo sedicente alleato sovietico, commentò amaramente: "Abbiamo
ammazzato il porco sbagliato!", il che la dice lunga sulla sua opinione
riguardo al tiranno russo.
Intanto, anche la sorte del Giappone si stava compiendo.
In gennaio, MacArthur era sbarcato a Luzon, il 17 febbraio Mac era tornato,
come aveva promesso nel 1942, a Corregidor e il 25 era entrato a Manila;
anche le città nipponiche subirono, a partire dal marzo 1945, pesanti
incursioni aeree, favorite dalla quasi completa distruzione dell’aviazione
del Sol Levante: Tokio, Osaka, Yokohama, Nagoia e Kabè pagarono un duro
prezzo; tra le città risparmiate, Hiroshima e Nagasaki avevano un
appuntamento con il destino.
Il 16 marzo, cadde Iwo Jima e il 1 aprile gli Americani sbarcarono a
Okinawa: la guerra ora minacciava direttamente l’arcipelago giapponese.
Mentre, una ad una, le isole del Pacifico cadevano, da Bougainville al
Borneo, gli scienziati americani stavano ultimando i test per la prima
esplosione atomica della storia: questa si realizzò ad Alamogordo, nel
deserto del New Mexico, il 16 luglio del 1945, segnando l’inizio dell’era
nucleare.
Il 6 ed il 9 agosto, due fratellini della bomba di Alamogordo, Little Boy e
Fat Man, consegnavano Hiroshima e Nagasaki alla storia ed i loro abitanti
all’olocausto atomico; il 15 agosto, l’imperatore ordinava di cessare ogni
ostilità.
Il 2 settembre, , alla fonda nella rada di Tokio, con la capitolazione
giapponese sul ponte della corazzata Missouri, finiva la seconda guerra
mondiale.
Le vittime sono state calcolate in circa 40.000.000, anche se il loro vero
numero non sarà mai calcolato.
Certamente incalcolabile è la mostruosa rovina, fisica e morale, che questo
conflitto ha procurato all'umanità, e all'Europa, in particolare.